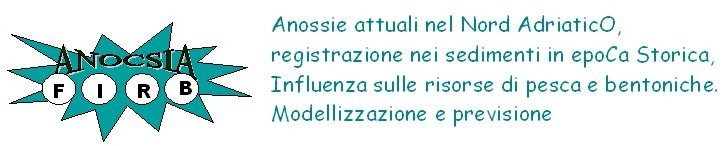Contesto
Le zone costiere di piattaforma continentale su cui sversano corsi d'acqua con bacino imbrifero esteso vengono già per natura alimentate da resti organici e sostanze nutrienti che innescano fioriture algali il cui ciclo e riciclo, è alla base della catena alimentare che rende l'area pescosa e fertile.
In bacini parzialmente chiusi e poco profondi come l'Alto Adriatico, soggetti a stratificazione delle acque, episodi straordinari, anche naturali, di emissione di sostanze nutrienti inducono fioriture algali imponenti. Queste possono, depositandosi sul fondo, produrre anossie soprattutto in presenza di acque stagnanti o confinate con conseguente stress delle popolazioni bentoniche e pelagiche di fondo.
L'occasionale sviluppo di situazioni anossiche sui fondali della piattaforma continentale induce gli organismi marini, e quindi anche le risorse oggetto di pesca, a comportamenti che, nella ricerca di situazioni ambientali tollerabili, ne aumentano la vulnerabilità ai predatori ed agli attrezzi da pesca (Fig. 1).
Alcune specie di pesci ed invertebrati hanno adattamenti fisiologici e biochimici che consentono loro di vivere in condizioni di marcata ipossia o di temporanea anossia, ma nessuna specie sopravvive in situazioni prolungate di anossia. Infatti, la gran parte delle specie è sensibile anche a moderate situazioni di sottosaturazione di ossigeno.
Per questo motivo, la grande estensione spazio-temporale delle anossie può determinare mortalità catastrofiche selettive rispetto alle singole specie, alterando i rapporti di abbondanza all'interno delle comunità biologiche. La ricolonizzazione delle aree interessate dalle morie può avvenire soltanto per trasporto passivo delle larve o migrazione attiva degli adulti da aree viciniori non interessate dal fenomeno. Tenendo presente che il ciclo vitale delle diverse specie che compongono l'insieme delle comunità bentoniche e delle risorse oggetto di pesca è generalmente pluriennale, risulta evidente che l'incremento di mortalità naturale conseguente ad una crisi anossica determina pesanti effetti economici sulla produzione ittica per alcuni anni. L'ipossia o l'anossia dei fondali che hanno luogo durante le maggiori crisi possono causare un generale depauperamento della fauna che, nei casi estremi, può portare alla completa defaunazione (Stachowitsch 1986; Justic et al. 1987; Crema et al. 1991; Lu & Wu 2000).
Questi fenomeni sono di particolare interesse per la piattaforma adriatica che ha subito e subisce attualmente episodi di limitazione stagionale dell'ossigeno disciolto nella colonna d'acqua e nei sedimenti di fondo, documentate dai dati di O2 raccolti in alcuni decenni di studi in questo settore (es. Degobbis et al. 2000), ma non esiste a tutt’ora un record esaustivo e sufficientamente rappresentativo di questa fenomenologia né esattamente si conosce quando questi fenomeni siano iniziati e quale sia stata la loro evoluzione storica recente.
Nel caso, attualmente più frequente, di forte antropizzazione dei bacini imbriferi fluviali, con aumento enorme dei carichi di sostanze organiche e nutrienti di origine civile, agricola e industriale, di cui la valle padana è un esempio, gli episodi anossici possono essere più frequenti nell'arco dell'anno e causare danni ingentissimi, anche perché ripetuti nel tempo, con ripercussioni, sia immediate che tardive, sull'intero ecosistema marino. Tuttavia, le ricadute sulle risorse demersali sono, in quest'area, di particolare interesse data la loro importanza socio-economica nei settori della pesca e del turismo (Froglia 1970; Gaston 1985; Orel et al. 1993).
Se però al variare delle attività umane, e quindi del tipo, stagione ed entità dello sversamento, gli effetti sull'ecosistema marino possono cambiare è importante sottolineare che tali variazioni, opportunamente guidate, potrebbero non aggravare situazioni di predisposizione naturale.
Tuttavia, per suggerire interventi di miglioramento è bene conoscere i meccanismi che regolano i rapporti di causa-effetto tra i vari processi in gioco sia a scala locale, costiera, che nel contesto più ampio dell'intera piattaforma adriatica settentrionale. Inoltre, è di fondamentale importanza individuare, nei meccanismi di innesco di tali fenomeni, quelli di origine naturale e quelli di origine antropica. Ciò al fine di costruire strumenti gestionali a diverse scale spazio-temporali che possano essere utilizzati nell'ambito di un contesto di coordinamento interregionale degli interventi, se non addirittura nazionale.Innovatività scientifico-tecnologica
Molti lavori sugli eventi anossici e ipossici sono stati per lo più affrontati, fino ad ora, con ottiche parziali e spesso indirizzati a specifiche strategie di intervento a breve termine. La grande importanza socio-economica di questa area ha spinto, infatti, la comunità scientifica a prodigare, nel tempo, notevoli sforzi per comprendere le fenomenologie legate a questi eventi, ma spesso gli sforzi sono stati disgiunti e senza una preventiva programmazione. In aggiunta a ciò, anche la possibilità di studiare solo le anossie in atto, e in particolare solo quelle segnalate, ha fortemente ridotto la capacità di comprendere le complesse interazioni tra la naturale predisposizione dell'ambiente, i forzanti legati al clima e l'influenza dell'uomo.
Per ovviare a queste problematiche, questo progetto si propone di studiare la fenomenologia degli eventi anossici nell’Adriatico centro-settentrionale, segnalati con una certa sistematicità solo a partire dagli anni ’70, combinandone le conoscenze dirette, derivate dalle registrazioni storico-strumentali e dai rapporti sull’andamento del pescato e sulle modificazioni delle sue caratteristiche commerciali effettuate in concomitanza con il presentarsi di detti eventi negli ultimi trent’anni circa, con le conoscenze indirette, derivate dalla loro registrazione fossile nel record sedimentario recente, al fine di ricostruire fenomenologia, tipologia, estensione e frequenza degli eventi anossici verificatisi negli ultimi 150 anni (Fig. 2 ).
A tal fine si intendono identificare e testare alcuni traccianti conservativi, già in parte utilizzati in altre regioni del mondo, che siano in grado di permetterci di ricostruire la distribuzione spazio-temporale degli eventi anossici e la loro frequenza in relazione alle condizioni meteo-climatiche, idrodinamiche e antropiche che hanno caratterizzato il bacino adriatico nell’ultimo secolo.
Per realizzare questi obiettivi è necessario poter disporre di serie temporali significative di eventi per poter ricostruire, in tutti i casi possibili, le dimensioni e la durata del fenomeno, cercando di risalire all'evoluzione delle condizioni ambientali che hanno portato all'anossia e che ne hanno determinato successivamente la scomparsa.
Per fare ciò è necessario esplorare il passato sia a memoria d'uomo sia nei record sedimentari. Questo progetto si propone dunque un duplice studio studio: 1) sulla colonna d’acqua per studiare le condizioni della colonna d’acqua che causano l’insorgenza dei fenomeni ipossici ed anossici e gli effetti che tali fenomeni hanno sulle risorse demersali; 2) sui fondali per ricostruire la cronistoria nel tempo degli eventi anossici. Gli indicatori paleoambientali geologici e geochimici possono infatti contribuire alla comprensione del fenomeno in maniera essenziale attraverso la caratterizzazione sia delle facies dei fondali attuali soggetti ad anossia sia delle paleofacies e, affiancati agli indicatori chimici e biologici, ci permettono di tracciare l'evoluzione storica recente dell'ecosistema marino. Dato che il Mar Adriatico nella fascia pelitica attuale è caratterizzato da un elevato tasso di sedimentazione (Bortoluzzi et al. 1996; Albertazzi et al. 1986; Frascari et al. 1987; Alvisi et al. 2001), possiamo ottenere un'alta risoluzione temporale degli eventi, fino ad un intervallo decennale, oltre al riconoscimento del limite pre/post-industriale e al conseguente impatto antropico.
A questo scopo diversi parametri saranno utilizzati tenendo però conto che le metodologie sviluppate per i record più antichi o per lo studio delle anossie attuali non possono, spesso, essere utili a causa dell'alterazione parziale o completa del segnale anossico dovuta al ritorno delle condizioni di ossigenazione del fondale. Inoltre, la scelta di focalizzare parte dell'attenzione sulle biocenosi dei fondali, e su quelle conservate nel record sedimentario, è giustificata dalla particolare stabilità nel tempo e nello spazio di queste biocenosi, la cui composizione e struttura è regolata, in larga misura, dalle caratteristiche del substrato in cui sono inserite.
Lo studio strutturale e funzionale di dette comunità, permette di rilevare le conseguenze di tali disturbi sia in concomitanza con l'evento stesso, sia a posteriori, in quanto la naturale tendenza al ristabilimento di una situazione di equilibrio passa inevitabilmente attraverso tappe di reclutamento e reinsediamento delle specie eventualmente distrutte dall'evento stesso, tappe che sono riconoscibili proprio dall'analisi strutturale e funzionale dell'intera comunità.